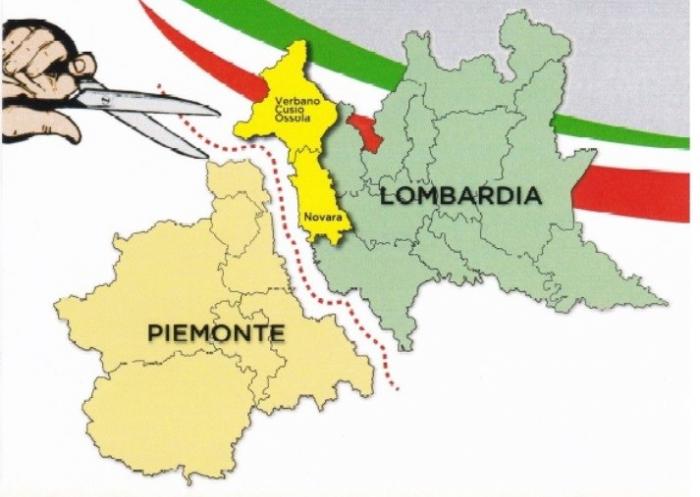Tornare dopo tanto tempo alla Cineteca di Algeri è una grande emozione e non solo perché la primaimmagine che si incontra all’entrata è un grande poster di La battaglia di Algeri di Gillo Pontecorvo.
Nonostante la ristrutturazione avvenuta tra il 2009 e 2010, sono ancora presenti foto – quella del fondatore Ahmed Hocine, nel 1964 manifesti e reperti che riportano agli anni in cui questo era un punto di riferimento per migliaia di giovani che qui hanno cominciato a conoscere i film di Jean Luc Godard, Orson Welles, Federico Fellini, Wenders e tanti altri. Erano gli anni sessanta, subito dopo la guerra di liberazione, quando un film e l’inevitabile dibattito che ne seguiva sfociavano nelle riflessioni sull’africanitudine e l’arabitudine di un paese che sognava un futuro radioso dopo 132 anni di colonialismo francese. L’esperienza algerina era un esempio per tutto quello che allora
ancora si chiamava terzo mondo e per le sue lotte di liberazione.
ALLA FINE DEGLI ANNI ’70 iniziava il trentennio a guida Boudjemaa Kareche, che all’inizio coincise con gli anni d’oro del cinema algerino. Sono gli anni di grandi scambi internazionali – ad Algeri si tenne allora il Festival del cinema panafricano – prima dell’inizio del declino. Che ha
raggiunto il suo culmine negli anni ’90 con il terrorismo.
L’occasione per tornare alla cineteca è la proiezione del film italiano Fuocoammare di Gianfranco Rosi, assente per impegni dovuti alla preparazione della partecipazione agli Oscar. Si tratta della seconda proiezione: la prima, come per tutti i film che hanno partecipato al Settimo Festival
internazionale del cinema di Algeri, era avvenuta nella sala El Mouggar, anch’essa ristrutturata e dotata di uno spazio per ricevimenti. Alla cineteca, dove si sono svolti anche tutti i dibattiti, l’ambiente è più «intimo» e ne approfitto per discutere con gli spettatori. Il film ha colpito molto le
persone presenti soprattutto perché hanno potuto vedere cosa aspetta i profughi al di là del Mediterraneo. «Conoscere l’isola di Lampedusa (in francese il titolo è Par-delà Lampedusa), la gente, il loro vivere quotidiano, oltre alla drammaticità della traversata e del salvataggio, è molto interessante», commentano i più. Il film di Rosi ha ricevuto un premio speciale dalla giuria.
IL FESTIVAL INTERNAZIONALE del cinema impegnato ha ottenuto un’ottima accoglienza tra i cinefili algerini che hanno seguito la proiezione di tre film al giorno e relativi dibattiti. La partecipazione è sicuramente un successo, tanto più che il Festival si è svolto contemporaneamente a quello dello spettacolo e della musica sinfonica. Per una settimana Algeri è diventata una capitale culturale e si è riempita di ospiti internazionali.
Sebbene sia stata la sala El Mouggar a ospitare le prime dei film, non è venuto meno lo spirito rivoluzionario, testimoniato da un grande manifesto con l’immagine del leader cubano appena scomparso e la scritta Fideles à Fidel («fedeli a Fidel»). La rassegna è stata dedicata proprio a Fidel
Castro. Un motivo in più d’orgoglio per la regista iraniana Rokhsareh Ghaem Maghami, premiata per il documentario Sonita. Per le fiction il premio è andato a I, Daniel Blake di Ken Loach, già Palma d’oro al Festival di Cannes 2016. Tra i nove documentari e sette fiction, altri riconoscimenti del pubblico (che votava a sua volta) e della giuria sono stati attribuiti ad Atentamente della colombiana Camelia Rodriguez Triana e a Invisible heroes di Alfonso Domingo e Jordi Torrent. Un premio della giuria anche a I am Nojoom, age 10 and divorced della yemenita Khadija al Salami. Mentre il pubblico ha preferito Spotlight. I molti premi assegnati testimoniano la difficoltà della scelta tra la
rosa di film impegnati proposti dal Comitato organizzativo del festival diretto da Zehira Yahi.
LE STORIE SONO EMBLEMATICHE della società in cui viviamo, sia in oriente che in occidente, al sud come al nord. In Sonita al centro è la storia di una profuga afghana in Iran che riesce a sfuggire a un matrimonio combinato e a diventare una rapper, per finire poi a studiare con una borsa negli Stati uniti. «Come gli Stati uniti? Dovevano essere proprio gli Usa a salvare la giovane profuga?», obietta qualcuno tra il pubblico. «Ho semplicemente raccontato la storia di Sonita, non potevo cambiarla. Io rispetto il mio paese…», si giustifica Rokhsareh. Un matrimonio forzato per la
piccola Nojoom si conclude invece felicemente con il divorzio. La storia di due ragazzine che si ribellano e sfidano la sorte. La regista di Nojoom, Khadija al Salami, ha fatto dell’oppressione della donna il tema dei suoi numerosi film, dopo aver subito in prima persona gli effetti di un matrimonio forzato quando era piccola. Sono comunque due film che danno una speranza alle bambine ancora
costrette a subire trattamenti medioevali, a essere vendute a vecchi danarosi e a subire violenze atroci.
POI LA GUERRA. Di liberazione algerina in Ouled Mokrane di Amor Hakkar, quella coloniale
portoghese in Angola in Lettres de la guerre del portoghese Ivo Ferreira, quella israelo-palestinese in Amori, furti e altre complicazioni del palestinese Muayad Alayan, la sconosciuta partecipazione di 85 afro-americani alle Brigate internazionali che hanno combattuto in Spagna per difendere laRepubblica in Invisible heroes. Infine Soy nero dell’iraniano Rafi Pitts, esiliato in Gran Bretagna, racconta di un messicano che vive negli Stati uniti e per ottenere la Green card si arruola nell’esercito americano, va a combattere in Medio oriente, ma quando dopo due anni torna dalla
missione viene espulso dagli Usa.
Interessante soprattutto la reazione del pubblico, che si è soffermato su aspetti non superficiali dei film e con un’ottica diversa da quella occidentale. Così è stata la perplessità manifestata di fronte al
film prodotto dalla Repubblica araba sahraui democratica, Leyuad. Il film è tutto imperniato sulla ricerca dell’identità poetica e filosofica del popolo sahraui con un viaggio nel deserto fino a Leyuad (che vuol dire Generosi), nel cuore del Tiris, «l’ancestrale terra degli uomini del libro». Il paesaggio,
«miracolo geologico di un luogo unico», è spettacolare tanto da risultare un’immagine da cartolina, quasi un paradiso viste le continue implorazioni rivolte a Dio dei poeti che riceveranno in dono dal loro ospite un Corano.
«Allora la storia sahraui si riduce al periodo islamico e l’identità è esclusivamente religiosa?» chiede uno spettatore (gli algerini sono molto sensibili al tema). «Noi abbiamo registrato il comportamento di questi personaggi senza avere una sceneggiatura da seguire e rendendo la nostra presenza e quella delle nostre apparecchiature il meno invasive
possibili. Loro sono così, per ogni scelta si rivolgono a Dio, ma è un rapporto personale», risponde Inés Aparicio, che ha curato la fotografia del film.
«E il fatto che la guerra non sia presente nel film è abbastanza sorprendente, vuol dire che i giovani rifiutano la guerra? Chiedo a Brahim Chagaf, il giovane regista sahraui. «No, al contrario, i giovani vorrebbero riprendere la guerra perché non ne conoscono gli effetti negativi, le sofferenze».
Il confronto non era con gli attori ma con i registi e produttori, quindi sui contenuti, senza nessuna sovraesposizione mediatica.
GLI ALGERINI hanno dimostrato il loro interesse per il cinema nonostante le difficoltà del settore e la scarsa disponibilità di sale per le proiezioni. Temi dibattuti nelle conferenze coordinate da un grande conoscitore del settore: Ahmed Bedjaoui. Zehira Yahi ha naturalmente dovuto far fronte alle scarse risorse messe a disposizione dal governo, come ha riconosciuto il ministro della cultura Azzedine Mihoubi, ricorrendo anche a sponsor privati.
La necessità di diversificare i finanziamenti, sottolineata anche durante il dibattito, tuttavia non è facile per una iniziativa culturale, sarebbe più facile per una partita di calcio.
Tuttavia il successo di questa settima edizione del festival ha posto le basi per la preparazione dellaprossima. «Sarà più ricca, spero, con più film e incontri professionali, con un pubblico maggiore e un numero superiore di registi provenienti dall’estero», è l’auspicio di Zehira Yahi.
il manifesto, 14 dicembre 2016