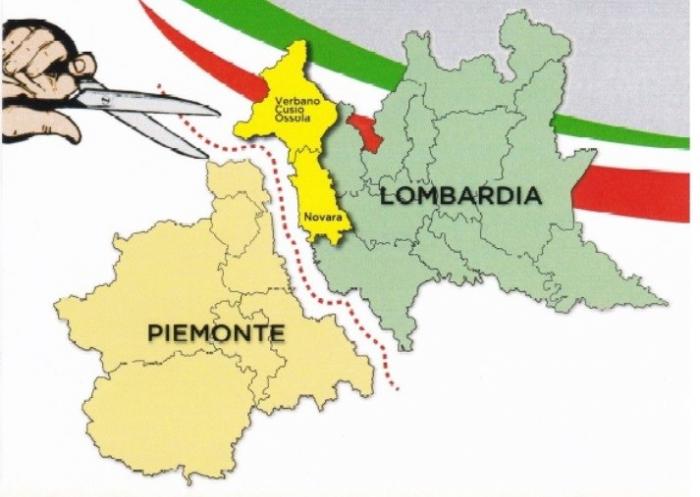Sono passati quindici anni dalla strage di Srebrenica, il più grande massacro di civili dopo la seconda guerra mondiale. A pochi chilometri, a Bratunac, un grande capannone verde spicca tra le molte case ricostruite dopo la guerra. Ospita la cooperativa “Insieme”, il cui nome appare a caratteri cubitali sulla facciata. “Insieme” per la conservazione dei lamponi. Siamo nel cuore di una delle zone più martoriate della Bosnia Herzegovina e “Insieme” è il simbolo della possibilità di convivenza tra serbi e musulmani. O meglio, serbe e musulmane, perché Rada Zarkovic ha voluto questa cooperativa con tutte le sue forze per dare a donne sole, a volte con figli da mantenere, la possibilità di lavorare e di avere un futuro.Quando è arrivata a Bratunac con donne profughe da Srebrenica, l”obiettivo di Rada, anche lei già profuga a Belgrado dove con le Donne in nero si era opposta alla guerra, era quello di dare concretezza al pacifismo, trasformare il suo ideale in realtà. Costruire la pace dando una prospettiva a quelle donne sole che portano sul loro corpo i segni della guerra, ferite profonde che non impediscono loro di parlare, ridere, anche piangere, ma insieme, serbe e musulmane. “Questo è un esempio di come si può elaborare il lutto, ma per farlo occorre la sicurezza, anche economica, altrimenti è più difficile. Se lavori insieme sei costretto a parlare, ad ascoltare, a capire il dolore dell”altro, l”elaborazione è un processo faticoso e lungo, non è facile recuperare i valori che una violenza dissennata ha distrutto”, dice Rada, che si definisce pacifista jugoslava, anche se la Jugoslavia non esiste più. La cooperativa “Insieme” creata nel 2003 da dieci soci oggi dà lavoro a una trentina di persone in maggioranza donne, ma c”è anche qualche uomo per i lavori pesanti, e conta su circa 400 produttori. La scelta è stata quella di recuperare e consolidare le attività esistenti nell”area e soprattutto una coltivazione tradizionale: quella dei lamponi. Sulle rive dalla Drina, da una parte e dall”altra – di là è già Serbia -, il clima è ideale per questa coltivazione, che non richiede grandi sforzi fisici ed è quindi praticabile anche da donne sole; con pochi investimenti una famiglia si può mantenere. Nel 2004 le donne capofamiglia erano 1.080, ora sono più che raddoppiate. La cooperativa fornisce le piantine di lamponi e poi trattiene il costo dal ricavo della raccolta. Il fatto che le piantine producano frutti per dodici anni è un investimento sul futuro e un incentivo a restare. “Chi comincia a produrre lamponi è tornato per restare”, dice soddisfatta Rada, anche se i problemi non mancano: prestiti da restituire con le minacce della crisi economica mondiale. E poi quest”anno le piogge non hanno favorito la produzione. Comunque la raccolta è iniziata. Verso sera cominciano ad arrivare i camion pieni di cassette di lamponi, Nermina – responsabile per quest”anno del raccolto – segna su un grande libro le quantità scaricate. Poi la catasta di cassette passa sulla grande pesa: sono oltre 600 chili, oggi. Ma siamo solo agli inizi. “Alcune sere arriviamo a 20 tonnellate e alla fine della stagione le tonnellate raccolte sono 400-450” , dice Rada. I lamponi vengono congelati e lavorati mentre passano su un nastro a 20 gradi sotto zero, poi esportati. La mattina presto irrompe il rumore roboante dei camion – il motore deve rimanere acceso per mantenere il congelatore in funzione – che porteranno i “lamponi della pace” in Germania. I frutti – ai lamponi si sono aggiunte more, fragole e mirtilli – non esportati sono trasformati in marmellate fatte con metodi tradizionali e senza aggiunta di conservanti. Questa è la nuova sfida di Rada: trovare una rete di distribuzione per le marmellate. Nermina, minuta e con capelli neri, al fianco di Rada ha ritrovato il suo sorriso, uno scopo nella vita e non cede alle pressioni della madre che la vorrebbe sposata. Sposata, con due figli, è invece la bionda Maya, l”altra donna che affianca Rada nella gestione della cooperativa. Nermina e Maya, così diverse e così uguali nella determinazione a riscattarsi dalle violenze subite in passato. Nessuna delle donne che ho incontrato qui vuole più sentirsi vittima.A Bratunac non sono arrivati, come a Srebrenica, risarcimenti che permettessero alle vittime della distruzione di ripristinare la propria abitazione eppure le case sono quasi tutte ricostruite anche solo con i mattoni e senza intonaco, ma già abitate. Anche Nermina e sua madre, rimaste sole dopo l”uccisione del padre e l”emigrazione dei fratelli, la casa se la sono rifatta da sole. I profughi sono ritornati a Bratunac, anche se la popolazione si è ridotta da 30.000 a 17.000, ora in maggioranza serbi, e la vita è ricominciata: lo si vede di giorno nei campi e la sera per le strade del centro della cittadina affollate soprattutto di giovani. A Srebrenica invece la situazione è completamente congelata. La città, che l”11 luglio del 1995 ha vissuto quello che il Tribunale internazionale per l”ex Jugoslavia istituito dalle Nazioni unite all”Aja ha definito genocidio, è ancora traumatizzata. Anche se su Srebrenica sono piovuti fiumi di soldi, forse più per tamponare i sensi di colpa dell”occidente che per aiutare veramente la popolazione ad uscire dal trauma provocato da quella tragedia. A Srebrenica, un tempo città ricca, città dell”argento (come dice il nome), ora le case distrutte durante la guerra sono state ricostruite, tutte belle e rifinite, ma spesso sono vuote. Si parla di 2.000 abitanti in città, compresi i serbi ancora ospitati in due campi profughi, ma il numero sale a 10.000 (sostiene il sindaco) se si considera tutto il comune, contro i 37.000 di prima della guerra. Ora la maggioranza è serba, prima della guerra era musulmana, e delle cinque moschee distrutte ne è stata ricostruita solo una, accanto alla chiesa. I soldi tuttavia non sono serviti come risarcimento morale, chi vive a Srebrenica continua a sentirsi una vittima, senza futuro. Quelli che tornano non sono i più poveri, anche perché l”assegnazione degli aiuti è stata affidata a una gestione locale corrotta che ha privilegiato non tanto la propria comunità ma i propri interessi, quelli di parenti o di chi era in grado di garantire un pacchetto di voti. Nelle elezioni di Srebrenica votano anche 10.000 profughi che non sono rientrati ma che servono per mantenere una “continuità” bosgnacca (bosniaco musulmana) e anche un legame con la città. Del resto anche il sindaco vive saltuariamente a Srebrenica. Così “i soldi sono serviti ad alimentare altro odio. E proprio non ce n”era bisogno”, afferma Rada Zarkovic. Eppure la popolazione di Srebrenica ha trovato un suo equilibrio, favorita anche dal fatto che non ci sono barriere fisiche, i quartieri non sono divisi per comunità, e ci sono punti comuni di incontro inevitabili: la posta, la banca, la società elettrica, che appartengono invece a una o all”altra componente nazionalista, sostiene Michele Biava, un cooperante italiano che vive da oltre un anno a Srebrenica. Naturalmente non mancano le tensioni, come una recente partita di calcio finita in rissa. Ma gli unici giovani che si vedono nella città quasi deserta sono proprio giovani che giocano in un campo di calcio. Il vero problema è che mancano prospettive per il futuro.Ora “a Srebrenica ormai arrivano solo i morti”, sussurra qualcuno, nessuno smentisce. Arrivano per essere sepolti l”11 luglio di ogni anno, nell”anniversario dell”orrendo massacro del luglio 1995, nel memoriale costruito a Potocari, a metà strada tra Srebrenica e Bratunac, in un enorme prato verde (una volta era un campo di grano) disseminato di lapidi bianche. Su una enorme lastra di marmo, che sembra abbracciare tutte le tombe, sono incisi i nomi dei circa 3.000 corpi sepolti e di tutti quelli che sono scomparsi per un totale di 8.372… (ma se ne potrebbero aggiungere altri). Si tratta di civili bosniaci musulmani rifugiatisi in una delle “zone protette” create dall”Onu a Srebrenica nel 1993 che i circa 400 caschi blu olandesi, sul posto, non hanno salvato dalle forze serbo-bosniache comandate dal generale Radko Mladic. Uno degli uomini più ricercati, che però non è mai stato catturato e ora la sua famiglia ne chiede la dichiarazione di morte. Proprio per aver preso parte a questi massacri un mese prima dell”anniversario, l”11 giugno scorso, il tribunale dell”Aja ha condannato 7 ufficiali dell”esercito serbo-bosniaco a pene pesanti, tre le quali due ergastoli per genocidio. Quest”anno saranno seicento le bare che racchiuderanno quel che resta dei corpi riconosciuti attraverso il Dna. L”11 luglio del 2009, è stato sepolto anche il padre di Nermina, ma lei non ha voluto partecipare alla cerimonia ufficiale, al memoriale è andata solo il giorno dopo. E non solo perché non riesce a superare quel trauma e il pensiero che il padre fosse rimasto con lei, malata, quando la sua famiglia era fuggita dalla “enclave” di Srebrenica per rifugiarsi a Tuzla, ma anche perché l”anniversario della strage è diventata l”occasione per una parata di politici e autorità che se ne dimenticano subito dopo. Dall”altro lato della strada, proprio di fronte al memoriale in quel che resta della fabbrica di assemblaggio che era diventata la sede del contingente delle Nazioni unite che avrebbero dovuto garantire l””enclave” musulmana, in un”ala della struttura è stato sistemato un piccolo museo sul massacro di Srebrenica, ma è sempre chiuso perché è gestito da un volontario e le richieste di visita sono rare. Il senso di abbandono è percepibile anche nel negozietto di “souvenir” sulla strada, di fronte al memoriale, che si è adattato a vendere un po” di tutto, oltre a cartoline e bicchieri che ricordano il massacro, si trovano dolciumi, servizi per caffé e uno scaffale pieno di veli musulmani ortodossi che qui le donne non portano. Qui il dolore non sembra aver trovato sbocco nella religione o nell”estremismo religioso come avviene in alcune altre zone della Bosnia. Anche a Bratunac c”è un memoriale con nomi e foto di circa 500 vittime serbo bosniache, ma è quasi nascosto, dentro un edificio, come se un lutto fosse diverso dall”altro e il nazionalismo ti perseguitasse anche dopo la morte. E invece il grande recinto che ospita la cooperativa Insieme è vissuta come un”oasi di pace. Del resto il nome della cooperativa “Insieme” era una giusta intuizione, ma perché un nome italiano? “Perché quando abbiamo fondato la cooperativa (con l”aiuto di alcune ong italiane, ndr), i tempi non erano ancora maturi, eravamo all”inizio del rientro… e non tutti avrebbero capito”.Ancora oggi non tutti capiscono ma l”impegno e l”ostinazione di Rada sono contagiosi, così come la solidarietà e la voglia di vivere di tutte le donne che lavorano con lei. E quando senti le risate fragorose delle lavoratrici di lamponi nella pausa caffé non immagineresti di trovarti a Bratunac. Forse è un sogno, quello di Rada.’
Srebrenica, quindici anni dopo
A Bratunac le donne lavorano Insieme

Preroll
Redazione Modifica articolo
7 Luglio 2010 - 11.52
ATF
Native
Articoli correlati