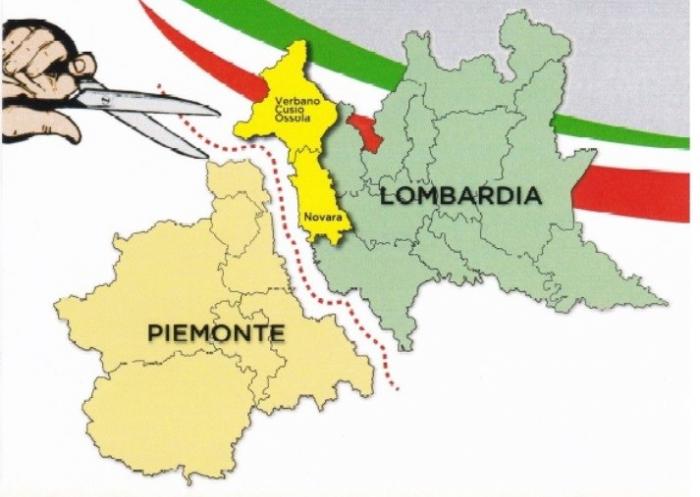Il film inizia con l”ultima scena, quella in cui sette protagonisti di Ghirdob (Vortice), restano uccisi da un missile lanciato dai taleban che allora, nel 1995, si trovavano alle porte di Kabul e cercavano di conquistare la capitale. La scena è terrificante ed è un documento eccezionale. Timur Akimiar è riuscito a conservare solo una copia del film – in Vhs e non in ottime condizioni – dalla furia dei taleban e la vediamo con lui nella sede disastrata dell”Unione delle associazione di artisti (registi, pittori, scrittori, architetti e musicisti) di cui Timur è presidente. La sede, una villetta nella zona residenziale di Wazir Akhbar Khan a Kabul, era stata già parzialmente distrutta, il piano superiore, durante gli scontri tra mujahidin, poi, quando sono arrivati i taleban hanno cacciato gli artisti, hanno distrutto tutte le opere, gli strumenti musicali, le suppellettili, i bagni e alla fine è diventata una sede di «al Qaeda», l”organizzazione di Osama bin Laden. Passata l”orda oscurantista Timur sta cercando di recuperare il salvabile e ricreare uno spazio culturale per gli artisti di Kabul, che già hanno ricominciato a bazzicare il luogo. Come l”architetto Maroof Bovary, laureatosi a Varsavia, dopo aver lavorato per anni con i polacchi, era diventato anche viceministro della difesa ai tempi di Massud, si occupava di ricostruzione e aveva preparato un piano per il recupero di Kabul, ma nel 1995 era stato buttato fuori dai mujahidin perché, dice, «non era favorevole ai mullah». «Mujahidin e taleban fanno parte dello stesso serial», aggiunge. Ha lavorato anche con il ministro della cultura taleban perché sperava, dice, «di ricostruire il museo, ma mi hanno solo sfruttato per ottenere finanziamenti dall”estero, che poi sparivano, perché i taleban non si curavano delle opere d”arte». Timur Akimiar che ha cominciato la carriera come attore, da giovane assomigliava moltissimo a Ninetto Davoli e ora, che è sulla quarantina, è invece una copia ringiovanita di Ciccio Ingrassia. Vivace, simpatico, è quasi sempre rimasto a Kabul in questi anni, nonostante le difficoltà, «cacciato dal centro degli artisti, per un po” sono rimasto senza lavoro, poi un amico mi ha convinto ad accettare un impiego al Ministero della cultura, svolgevo solo alcune mansioni puramente burocratiche per avere un salario, anche perché l”arte con i taleban era tabù. Alla fine però i taleban hanno cominciato a darmi la caccia e, due anni fa, sono scappato in Pakistan, per cinque mesi, poi sono tornato».Timur ricorda con nostalgia, mentre mi accompagna ad incontrare un suo amico poeta, i tempi di Najibullah, quando il centro degli artisti era frequentato da decine di delegazioni straniere e godeva di molti finanziamenti. Quando Kabul era una città moderna e le donne vestivano all”occidentale, come testimonia il primo film da lui girato come regista e di cui è riuscito, proprio in questi giorni, a recuperare la copia che teneva nascosta dietro una finta parete in una casa a una ventina di chilometri da Kabul. Anche Giovideman (Giovide mio, questo il titolo del film) come «Vortice» è una storia d”amore che finisce male: in «Vortice» la ragazza innamorata di un ragazzo ma promessa a un uomo potente e mafioso si suicida e il suo innamorato la vendica facendo una strage ma finisce in galera. Giovideman invece è la storia di due innamorati, il ragazzo è uno studente che studia all”estero e proprio un giorno mentre sta partendo da Kabul resta vittima di un attentato all”aeroporto. Era l”epoca degli scontri tra i mujahidin e anche in questo caso la realtà si sovrappone alla fiction: la ragazza ha il brutto presentimento che l”aereo venga abbattuto – e nel film questo presentimento viene illustrato con l”unico filmato esistente sull”abbattimento da parte dei mujahidin di un aereo vicino a Khost, al confine con il Pakistan -, mentre il ragazzo morirà ma in un attentato all”aeroporto. I responsabili saranno arrestati e confesseranno, ma anche questa parte riproposta nel film risulterà poco gradita ai nuovi padroni di Kabul.Probabilmente i guai non sono finiti per Timur che, pur rendendosene conto, preferisce essere ottimista. Ora sta scrivendo la sceneggiatura di un nuovo film, il soggetto è altrettanto drammatico e scabroso, si tratta di fatti realmente accaduti, racconta Timur, si tratta del rapimento di numerosi bambini (una sessantina), avvenuto un paio di anni fa, da parte di una banda di afghani in collegamento con pakistani. I bambini venivano circuiti da donne con burqa, fatti salire su macchine, a volte narcotizzati e poi uccisi per prelevare organi da trapianto, soprattutto cornee e parti dello stomaco. «Noi avevamo paura e non lasciavamo più uscire i bambini da soli per strada», ricorda. All”interno della banda vi erano anche medici che poi trasferivano gli organi in contenitori frigorifero in Pakistan, alcuni responsabili erano stati arrestati dai taleban, ma non sono stati processati, forse perché c”erano delle connivenze con il regime. Poi con la fuga dei taleban le prigioni sono state aperte e tutti i prigionieri fuggiti, compresa questa banda di criminali. Ma il regista non vuole rinunciare alla denuncia.Con l”aiuto di Timur riusciamo a rintracciare Sher Mohammad Khara, poeta, anche lui non ha mai lasciato il paese e ci mostra una sua foto dei tempi dei taleban, con una lunga barba, che ora ha conservato ma molto ridimensionata. Un”aria gioviale, sorridente, ci accoglie nei locali di Kobura (il vecchio nome di Kabul), l”organizzazione non governativa da lui diretta (ai tempi dei taleban aveva invece una scuola di informatica), nonostante le pressioni dei suoi collaboratori, soprattutto un tedesco – il cui governo ha finanziato in buona parte i progetti che sta realizzando – che gli fanno fretta. Ci ritiriamo nel suo ufficio e Mohammad comincia a tirar fuori da un cassetto cartelline di plastica verdi e blu, dove ha conservato i suoi poemi che ora spera di pubblicare.Negli anni dei taleban un gruppo di scrittori e poeti, tra cui Mohammad Khara che ne era l”organizzatore e l”ispiratore, si riunivano, clandestinamente naturalmente, sempre in luoghi diversi e per non più di un”ora, per scambarsi opinioni e anche scritti che venivano fotocopiati e fatti circolare tra amici e conoscenti. In tutto erano una quindicina e la presenza di due donne – come la poetessa Nazifa Khochnassib, che di professione fa il medico ma che ha resistito ai taleban scrivendo poesie – rendeva gli incontri ancora più pericolosi: se i taleban li avessero scoperti la condanna a morte era certa. Il gruppo esisteva prima ancora dell”arrivo dei taleban ma il terrore imposto dagli ex studenti di teologia aveva indotto qualcuno ad abbandorare gli incontri, mentre altri, come Nazifa e la sorella maggiore, docente di fisica, si erano aggiunti. Nel malaugurato caso in cui i taleban li avessero sorpresi l”indicazione era quella di fingersi in preghiera e per questo portavano sempre una copia del corano. E quando una volta è successo, hanno finto una veglia per un conoscente morto. Fortunatamente il miliziano taleban ci aveva creduto.Mohammad Khara tira fuori dalle cartelline i suoi manoscritti, tutti ordinati e raccolti in fascicoli, su una copertina fotocopiata una fila di tombe e un titolo: Tabut («Bara»). E poi altri ancora: «Attraverso la storia», «Addio primavera», «Il rumore del tamburo». Un”altra copertina con un corpo dilaniato e un urlo che esce da una bocca scolpita su un viso tumefatto: «puoi sentire la mia voce?» La voce finché c”erano i taleban non è mai uscita da queste quattro mura, ma ora può farlo con la forza della testimonianza. Quella di Mohammad Khara, che trasmette la calma dei forti, di chi non ha mai voluto lasciare Kabul «perché volevo stare con la mia gente. Ho sempre creduto nella democrazia, per questo ho sempre avuto problemi per la pubblicazione delle mie opere anche con i mujahidin e con Najibullah, allora sono stato in carcere per la prima volta».Ma la storia si è ripetuta con i taleban: è finito in prigione due volte, la prima per una settimana e la seconda per un mese. «Ma sono stato fortunato perché sono ancora vivo», dice sfoderando un ampio sorriso. Ora invece i problemi per la pubblicazione di queste opere sono soprattutto i soldi. E come per rompere l”incantesimo Mohammad legge una delle sue poesie in dari, Timur traduce: «il suono del fucile squarcia la pace della foresta, una giovane con il corpo ferito, coperto di sangue, cade al suolo, il tempo di esclamare ah! e muore».Ogni tanto qualcuno irrompe nell”ufficio per prelevare una mazzetta di afghani da una pila di soldi, che servono per pagare gli insegnanti – in tutto 600, tutte donne – che hanno tenuto i corsi di recupero per 15.000 bambine, escluse dalle scuole ai tempi dei taleban. «Abbiamo anche dovuto riabilitare e attrezzare le scuole, mentre l”Unicef ha fornito il materiale scolastico», racconta il poeta mentre ripone accuratamente i suoi scritti nelle cartelline. Il lavoro non è tuttavia finito con la riapertura delle scuole il 23 marzo, in aprile cominceranno i corsi di alfabetizzazione per adulti: in Afghanistan il 90 per cento delle donne sono analfabete. E non è finita. Mohammad è un vulcano di idee, ha aperto un centro culturale che pubblica anche un settimanale dal titolo: Sar Zamin-e Man («Il mio paese»), il primo numero, allora era solo un foglio, è uscito proprio il giorno in cui i taleban hanno abbandonato Kabul. Con una vignetta estremamente significativa sulla paura che ancora regna in Afghanistan: una donna è rinchiusa in una cella, qualcuno, attraverso le sbarre, le tende la chiave della porta, ma lei non la prende.Yusuf, il fotografo, invece lo conoscono in molti, ma è difficile rintracciarlo impegnato com”è a caccia di eventi da immortalare. Adesso le foto si possono fare, non come ai tempi dei taleban. Alla fine lo troviamo proprio alla sede del giornale per il quale lavora, Kabul times. Al pian terreno la tipografia, macchine obsolete piene di polevere, ai piani superiori la redazione fatta di stanze spoglie, giornalisti che vanno e vengono. E” difficile immaginare che da queste stanze possa uscire un giornale, eppure ogni settimana Kabul times viene pubblicato. Yusuf, 33 anni, ricorda l”arrivo dei taleban a Kabul, quando durante i bombardamenti ha perso il padre e una sorella e lui porta ancora una scheggia conficcata in testa che non lo lascia dormire. Ci mostra la cicatrice malamente nascosta sotto un berretto a caschetto di foggia americana. Fuma una sigaretta dopo l”altra e si agita mentre cerca una foto tra un pacco di vecchie immagini. Da qualche anno però ha una macchina digitale. Lui le foto le ha sempre fatte, perché i taleban, racconta, vietavano solo le immagini degli esseri viventi «e io fotografavo edifici, strade e cose del genere».I guai sono cominciati quando il suo giornale ha pubblicato una sua foto che ritraeva un ministero ma non si era accorto che su un lato vi era un operaio che stava pitturando una parete. E così è finito in galera per la prima volta e non sarebbe stata l”ultima (altre due volte è stato in carcere e picchiato). Finché i ministri taleban non si sono appassionati alla fotografia e hanno scoperto che bastava farsi fotografare da Yusuf e poi sequestrargli i rullini o la scheda digitale per far sparire le tracce della loro trasgressione. Così la storia è andata avanti dal 1997. Con un tira e molla continuo, veniva arrestato poi ricorreva al ministro di turno che in cambio di qualche foto lo rilasciava: «con i taleban non ci si poteva difendere con le parole – si giustifica – dovevo pur trovare il modo per dar da mangiare ai miei figli».Nel suo archivio sostiene di avere 70.000 rullini che ora vorrebbe tirare fuori. E come si sente ora? «Io avevo un uccello in una gabbia e avevo promesso che quando i taleban se ne fossero andati lo avrei liberato. Così ho fatto e anch”io ora mi sento libero». E ricorda i taleban che picchiavano la gente, che mandavano a pregare alla moschea, «ma l”islam è nel cuore, non serve andare alla moschea». Ma poi, con le lacrime agli occhi rammenta la miseria in cui vivono gli afghani, che hanno bisogno di aiuti, «questa volta l”occidente non può abbandonare l”Afghanistan», sostiene il fotografo. Ha bisogno di credere che gli occidentali sono venuti veramente per aiutarli, proprio come Peter, un inglese che per due anni, durante il regime dei taleban, aveva aiutato Yusuf mandandogli 5.000 rupie pakistane (circa 80 dollari) al mese.’
Gli amanuensi della libertà
Gli intellettuali afghani escono allo scoperto dopo gli anni oscurantisti dei taleban al potere. Poeti, registi, scrittori e fotografi guardano con speranza alla nuova realtà di Kabul, ma senza nascondere le contraddizioni provocate dalla guerra e le

Preroll
Redazione Modifica articolo
3 Aprile 2002 - 11.52
ATF
Native
Articoli correlati